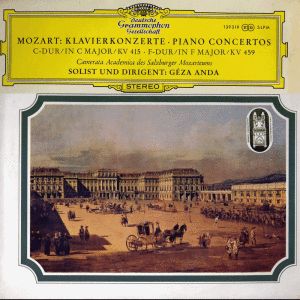Scarica qui la Missa Solemnis di Beethoven
La prima esecuzione della prima versione avvenne a Budapest nel 1889, quando Mahler era direttore del Teatro dell’Opera, e fu presentata come poema sinfonico in cinque movimenti intitolato Symphonische Dichtung in zwei Teilen (Poema Sinfonico in due parti). L’accoglienza del pubblico ungherese non fu molto calorosa ed il compositore decise di apportare delle modifiche che chiarissero meglio il significato del lavoro.
Nelle successive esecuzioni ad Amburgo (1893) e Weimar (1894), la composizione fu intitolata Titan. Eine Tondichtung in Symphonie-form (Il Titano. Poema sinfonico in forma di sinfonia).
Per la versione di Amburgo Mahler decise di aggiungere alla composizione il titolo di Titano (ispirato a Der Titan romanzo di Jean Paul), un programma dettagliato per descrivere in modo più chiaro i movimenti ed i titoli per le due parti:
Aus den Tagen der Jugend – Blumen-, Frucht- und Dornstücke (Dai giorni della giovinezza – Fiori, frutti e spine)
I Frühling und kein Ende (Primavera senza fine)
II Blumine
III Mit vollen Segeln (A vele spiegate)
Commedia Humana
IV Gestrandet! Ein Todtenmarsch in “Callots Manier” (Arenato! Una marcia funebre alla maniera di Callot)
V Dall’Inferno al Paradiso
Dopo altre revisioni, Mahler decise di eliminare il titolo dell’opera, i titoli che descrivevano i movimenti, ed il secondo movimento originale, l’Andante, intitolato Blumine. La prima esecuzione di questa ultima revisione della composizione – una Sinfonia in Re maggiore, senza numero – avvenne a Berlino nel 1896, per una durata complessiva di circa 55 minuti.
Il titolo definitivo di Sinfonia n. 1 apparve in occasione della prima edizione a stampa del 1899.
Donizetti:
Don Pasquale
Scarica qui Don Pasquale di Donizetti
Don Pasquale, dramma buffo in tre atti, libretto di Giovanni Ruffini.
Registrazione effettuata negli studi EMI di Abbey Road (Londra) dal 1 al 4 e dal 7 al 9 agosto 1978
Ambrosian Opera Chorus
Maestro del coro John McCarthy, buffo
London Simphony Orchestra diretta da Sarah Caldwell
Don Pasquale: Donald Gramm
Vecchio celibatario tagliato all’antica
Dottor Malatesta Alan Titus, baritono
Uomo di ripiego, medico e amico di Don Pasquale e amicissimo di
Ernesto Alfredo Kraus, tenore
Nipote di Don Pasquale, amante corrisposto di Norina
Norina Beverly Sills, soprano
Giovane vedova
Un notaro Henry Newman, baritono
Don Pasquale è un dramma lirico in tre Atti, musicato da Gaetano Donizetti tra il novembre e il dicembre del 1842, su libretto di M.A. [ Giovanni Ruffini
tratto da Ser Marcantonio (Parigi, 1808) di Angelo Anelli. Don Pasquale venne rappresentato per la prima volta a Parigi, al Théâtre des Italiens, il 3 gennaio 1843, sotto la direzione di Théophile Alexandre Tilmant.
LA PARTITURA MANOSCRITTA
La partitura manoscritta autografa è nell’Archivio Ricordi di Milano.
IL LIBRETTO
Solisti della prima rappresentazione parigina, al Théâtre des Italiens, il 3 gennaio 1843:
Norina – soprano – giovane vedova, natura subita, impaziente di contraddizione, ma schietta e affettuosa (Giulia Grisi)
Ernesto – tenore – nipote di Don Pasquale, giovane entusiasta, amante corrisposto di Norina (Giovanni Matteo de Candia)
Don Pasquale – buffo – vecchio celibatario, tagliato all’antica, economo, credulo, ostinato, buon uomo in fondo (Luigi Lablache)
Dottor Malatesta – baritono – uomo di ripiego, faceto, intraprendente, medico e amico di Don Pasquale e amicissimo di Ernesto (Antonio Tamburini)
un notaro – tenore – (Federico Lablache)
Coro di servi
Maggiordomi, modista e parrucchiere che non parlano
LA TRAMA
L’azione si svolge a Roma
Atto I
Sala in casa di Don Pasquale, con porta in fondo d’entrata comune, e due porte laterali che guidano agli appartamenti interni.
Don Pasquale, vecchio ricco e scapolo, è arrabbiato col nipote Ernesto che vuole sposare Norina, vedova bella, ma povera. Decide allora di prendere moglie per punire il giovane e diseredarlo. Il dottore Malatesta comunica a Don Pasquale di conoscere la ragazza che fa per lui: sua sorella Sofronia (“Bella siccome un angelo”), dal carattere docile, appena uscita dal convento. Ernesto è disperato, non può coronare il suo sogno d’amore (“Sogno soave e casto”) e scrive una lettera d’addio a Norina. Nella sua camera la bella Norina sta leggendo un libro d’amore (“So anch’io la virtù magica”) e, nel ricevere la posta di Ernesto, cade nel più profondo sconforto. Malatesta la rassicura e le spiega di aver organizzato per il vecchio Don Pasquale un matrimonio fasullo. Finta è la sposa perché è la stessa Norina nelle vesti di Sofronia, e finto è pure il notaio.
Atto II
Sala in casa di Don Pasquale
Ernesto compiange la sua sorte (“Cercherò lontana terra”) mentre suo zio è tutto in ghingheri per ricevere la sposa. Arrivano Malatesta e Sofronia (Norina travestita). Don Pasquale rimane colpito e affascinato dalla bellezza e dal comportamento umile della ragazza (“Via da brava”). Si celebra il matrimonio ed Ernesto, che fa da testimone, riconosce Norina, ma viene subito informato da Malatesta della burla, e sta allo scherzo di buon grado. Firmato il contratto nuziale Sofronia si rivela una padrona di casa autoritaria e prepotente (“Voglio, per vostra regola”): raddoppia la paga alla servitù , progetta spese folli e minaccia Don Pasquale.
Atto III
Sala in casa di Don Pasquale, come nell’Atto I e II. Sparsi sui tavoli, sulle sedie, per terra, articoli di abbigliamento femminile, abiti, cappelli, pellicce, sciarpe, merletti, cartoni …
Le pretese di Sofronia aumentano (“I diamanti, presto, presto”) e Don Pasquale non riesce ad impedirle di andare a teatro, sebbene sia la prima notte di nozze (“Dove corre in tanta fretta”). La giovane moglie, uscendo, fa cadere volutamente un foglietto per far pensare a Don Pasquale che ella abbia un amante. Adirato il povero marito chiama il dottor Malatesta e insieme decidono di appostarsi in giardino per sorprendere i due innamorati (“Cheti cheti immantinente”). Ernesto, come suggerito dalla sottile regia di Malatesta, finge di essere l’amante di Sofronia e canta la serenata “Com’è gentil la notte a mezzo april”. I due giovani si abbracciano e si dichiarano il reciproco amore (“Tornami a dir che m’ami”). Don Pasquale e Malatesta escono dal nascondiglio, Ernesto fugge e Sofronia si difende dalle accuse, mostrandosi indignata. Il dottore le annuncia che in casa di Don Pasquale si stabiliranno d’ora in poi Ernesto e Dorina come marito e moglie. Sofronia finge ancora di essere adirata e minaccia di andarsene. Don Pasquale, ben felice di liberarsi da una consorte così bisbetica, dà il consenso alle nozze del nipote. Arriva Ernesto e Malatesta svela l’inganno a Don Pasquale, che appresa la lezione, benedice i due giovani (“La moral di tutto questo”).
SCENA ULTIMA
Norina
La moral di tutto questo
è assai facile trovar.
Ve la dico presto presto
se vi piace d’ascoltar.
Ben è scemo di cervello
chi s’ammoglia in vecchia età ; va a cercar col campanello
noie e doglie in quantità .
Don Pasquale
La morale è molto bella
applicarla a me si sta.
Sei pur fina, o bricconcella,
m’ha servito come va.
Malatesta ed Ernesto
La morale è molto bella,
Don Pasqual l’applicherà .
Quella cara bricconcella
lunga più di noi la sa.
FINE
MAHLER
Sinfonia Nr.4 in sol maggiore
Gustav Mahler: Sinfonia n°4
Recensione di: Senmayan , (Thursday, February 09, 2006)
Mozart sonate eseguite
da Lodovico Lessona
Sonata in do Maggiore K. 330 allegro moderato, andante cantabile, allegretto