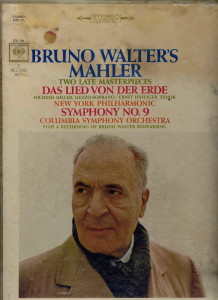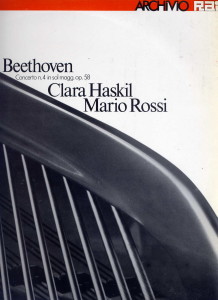Scarica qui il concerto triplo di Beethoven
Il concerto triplo per pianoforte, violino, violoncello e orchestra
di Ludwig van Beethoven, composto tra il 1803 e il 1804, appartiene
allo stesso periodo della terza sinfonia e sonata per pianoforte
“Appassionata”. Fu scritto appositamente per l’Arciduca Rodolfo che
in quegli anni era diventato suo allievo di pianoforte e per i due
solisti a suo servizio, il violinista Carl August Seidler e il
violoncellista Anton Craft, ambedue ottimi virtuosi.
È il primo concerto in assoluto che fu concepito per quel tipo di
complesso. Durante la vita di Beethoven fu eseguito una sola volta,
ed anche dopo la sua morte è raramente entrato nelle sale da
concerto, colpa delle accuse di ‘mediocrità’ da parte dei
concertisti dell’epoca, oltre che per l’inusuale presenza di tali
strumenti concertanti insieme.
È formato da tre movimenti:
1.Allegro
2.Largo
3.Rondò alla polacca — Allegro — Tempo I
Gerontius Peter Pears
The Priest John Shirley-Quirk
The Angel Yvonne Minton
The Angel of Agony John Shirley-Quirk
With the London Symphony Chorus (Corus Master Arthur Oldham)
The Choir of King’s College, Cambridge (Director: David Willcocks)
The London Symphony Orchestra conducted by Benjamin Britten
Lato 1
Parte prima: Preludio, Jesu, Maria, I am near to death
Lato2
Parte prima: (Conclusione) Proficiscere, anima Christiana
Parte seconda: I went to to sleep: and now I am refreshed.
Lato 3
PartII : (Continued): But hark! Upon my sense comes a fierce hubbub
Lato 4
Part II (concluded); Thy judgement now is near
La Decca ha pubblicato di recente due microsolco nei quali è registrato un oratorio che sta fra le musiche ricordate del nostro secolo. Si trata di una vasta composizione di Edward Elgar, l’insigne compositore inglese vissuto fra il 1857 e 1934 intitolata The dream of Gerontius, cioè a dire il sogno di Geronzio.
Scritta su testo del cardinale Newman, è in sostanza una vera e propria opera in due atti (così affermano gli studiosi elgariani). In effetto laparticolare impronta della partitura richiama lo spettacolo operistico nella sua scolpitezza, nella sua vis drammatica, nella sua tension e espressiva e anche nei suoi forti effetti.
Ma di là da tale specifico carattere The dream of Gerontius è una pagina bellissima, tutta ispirata, lavorata, di fino con sapienza e con minuzia.
A mio parere questa pubblicazione Decca è una fra le più importanti dell’annata discografica in corso: non soltanto si badi per l’interesse del titolo, non soltanto per la rarità con cui il titolo è presente nei cataloghi discografici, ma anche per la validità assoluta dell’esecuzione affidata a quel sensibile e acuto direttore che risponde al nome di Benjamin Britte, ossia del capofila della giovane scuola inglese; un compositore fra i pèiù eminenti oggi.
Inutile dire che Britten ha rilevato nella partitura elgariana tutti i più sottili valori, in essa cogliendo quell’aura di mistero e di soprannaturalità, quell’umanissimo calore, quei passionati cintrasti psicologici, quella straordinaria intensità nella compinazione voci-strumenti che rapiscono e incantano chi ascolta.
Nella parte di Geronzio figura un interprete di riconosciuti meriti, il tenore Peter Pears il quale è riuscito a uguagliare la meravigliosa finezza conseguita nello strumentale da Benjamin Britten.
Nella parte del Prete e dell’Angelo dell’Agoniail bravissimo baritono John Shirley-Quirk, assai versato come tutti sappiamo nell’interpretazione delle musiche di autori inglesi; nella parte dell’Angelo il mezzosoprano Yvonne Minton, una cantante di finissima scuola che ha più volte collaborato con successo alle imprese discografiche della Decca.
Ai meriti indiscutibili dei solisti bisogna aggiungere quelli dei cori della London Symphony e del King College Cambridge istruiti rispettivamente da Arthur Oldham e da David Wilcocks. Il coro dei Diavoli “Low-born clods of brute earth”, il coro degli Angeli “Praise the Holiest in the Height”, il coro delle voci in terra e delle anime in Purgatorio sono in effetti modelli esemplari di fusione vocale e di finezza interpretativa. L’orchestra della London Symphony è un gioiello, fra mano a Britten.
Segnalo perciò con entisiamo i due dischi Decca ai miei lettori e consiglio l’acquisto di questa bella edizione discografica dell’oratorio elgariano.
Vale la pena a mio parere di conoscere The dream of Gerontius e il suo autore. . Sotto il profilo tecnico i due microsolco sono di buona fattura, senza alcuna menda riconoscibile.
Laura Padellaro.
eseguiti da
Das Beaux Arts Trio
(Menahen Pressler Klavier, isidore Cohen violino, Bernard greenhous Violoncello)
Due Klaviertrio, di Smetana e di Chopin.
Lato A
Bedrich Smetana
Klaviertrio g-moll op.15
Lato B
Frederic Chopin
Klavietrio g-moll op.8
Aria e coro dal “Messiah” di Handel
The London Phylharmonic Choir with the London Philharmonic Orchestra
Diretta da Sir Adrian Boult.
Jennifer Vyvyan Soprano
George maran Tenore
Norma Procter Contralto
Owen Brannigan Basso
Quattro sinfonie
Concerto per violino
Variazioni su un tema di haydn
Requiem tedesco
Two late masterpieces
Das Lied von der erde
Milder miller mezzosoprano, Ernst Hafliger tenore
New York Philarmonic
Symphony N.9
Colunbia Symphony Orchestra
Plus a recording of Bruno Walter rehearsing.
Scarica qui il concerto n.4 di Beethoven
Lato A: Allegro moderato
Lato B: Andante con mto
Allegro vivace.
Clara Haskil pianoforte
Orchestra sinfonica della Rai di Torino diretta da Mario Rossi
Registrazione dal vivo effettuata il 22 aprile 1960 nell’Auditorium di Torino della Rai.
Non c’è nessun concerto per pianoforte che cominci come il quarto di Beethoven. In molti concerti è l’orchestra che inizia esponendo da sola il materiale del primo tempo, in molte altre orchestra e pianoforte iniziano insieme, in qualcuno il pianoforte scarica subito le sue carte in tavola con una cadenza virtuosistica.
Ma solo nel Quarto di Beethoven il pianoforte è messo nella condizione di dover cominciare da solo, suonare quietamente cinque battute e poi tacere durante tutta l’esposizione dell’orchestra. Sembra una cosa da niente, ed è terrorizzante tanto che Artut Schnabel , quando gli chiedevano quale fosse il più difficile concerto per pianoforte e orchestra rispondeva invariabilmente: “Il quarto di beethoven”.
E dopo l’immancabile perchè dello stupito interlocutore aggiungeva: perchè appena cominciato il pianista ha un minuti di tempo per pensare a quanto ha suonato già male.
Nelle cinque famigerate battute del quarto non c’è difficoltà meccanica che vada al di là di una modesta scaletta di otto suoni, ma Schnabel aveva ragione. Perchè non si tratta di iniziare con cose difficile, si tratta di iniziare facendo nascere la poesia.
Clara Haskil non era forse una grande pianista nel senso solito del termine, e non era neppure un’interprete che arrivasse a sintesi totalizzanti: non era in altre parole nè un Horowitz nè un Gieseking. Ma quando, trovata faticosamente la posizione del suo corpo piegato dall’artrite, toccava la tastiera e faceva uscire dal pianoforte le prime note del Quarto concerto, l’ascoltatore sentiva nascere la poesia!
Sonata n.1 in fa maggiore
Sonara n.2 in do maggiore
Sonata n.3 in si bemole maggiore
LatoB:
Sonata n.4 in sol maggiore
Sonat n.5 in re maggiore
Sonata n. 6 in mi bemolle maggiore
Per questa incisione è stato impiegato un fortepiano.
La scelta potrà a prima vista sollevare qualche interrogativo dato che il titolo del lavoro è “Sei sonate per cembalo” ma è perfettamente adeguata. All’epoca delle composizioni delle sonate il fortepiano era ormai di uso comune anche se non esclusivo; il suo nome per esteso era cembalo col forte e col piano da cui nascerà da cui più tardi per contrazione il nome che noi ora usiamo: fortepiano o pianoforte.