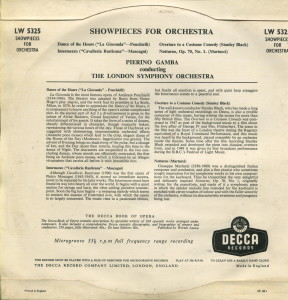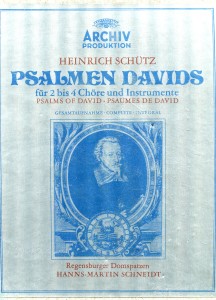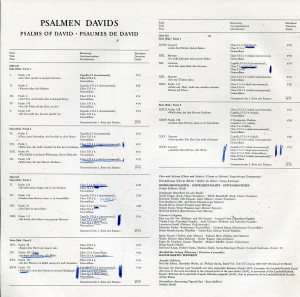Risposta
Mahler: Symphony n.1 in D major
The Titan
Bruno Walter conducting the Columbia Symphony Orchestra
Lato A
1
Langsam
2
Kraftig bewegt
3
Feierlich und gemessen (beginning)
Lato B
1
Feierlich und gemessen (conclusion)
2
Stumisch bewegt
Si tratta di otto lp con musiche di Monteverdi, Frescobaldi, Corelli, Couperin, Vivaldi
otto lp con musiche di Dvorak, Frank, Grieg ,Musorgskjj Cajkowskj…
Si tratta di 8 lp dedicata Beethoven.